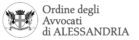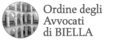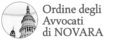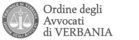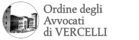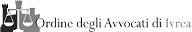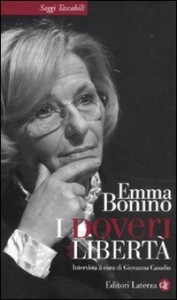La versione di Emma Giovanna Casadio intervista Emma Bonino Protagonista di un modo diverso di fare politica, ne I doveri della libertà Emma Bonino racconta il lungo cammino per i diritti che ha rivoluzionato il costume e la politica del nostro paese. Qui proponiamo un breve estratto dell’intervista a cura di Giovanna Casadio. Il mercato, la libertà e le regole […] D. Deve convenire che se si privilegia la libertà d’impresa, prima o poi in presenza di una crisi economica saranno i diritti sociali – il diritto all’occupazione, al welfare – a soccombere. Se si sta dalla parte dell’amministratore delegato della Fiat Sergio Marchionne e delle legittime ragioni di delocalizzare, di ristrutturare in base a una maggiore competitività sul mercato, di efficienza, ecc., il prezzo lo pagano i lavoratori di quegli stabilimenti in termini di minore occupazione, minori tutele, più turni di lavoro, in una parola nell’arretramento dei loro diritti. Questo è l’altro esito del liberismo. R. Se noi leviamo di mezzo le interpretazioni catastrofiste, filosofiche più che economiche, della mondializzazione del mercato, e leggiamo la crisi economica come una crisi nel mercato ci rendiamo facilmente conto che quell’apertura ha determinato straordinarie opportunità di crescita e di maggiore benessere in tutto il mondo, non solo nei paesi ricchi: sicuramente ponendo anche dei problemi nuovi, che vanno affrontati, governati e risolti, non esorcizzati. La concorrenza dei paesi emergenti sui prodotti a basso contenuto tecnologico ha determinato, per dire, la riduzione drammatica del costo del lavoro del personale non qualificato e in generale una diminuzione del potere contrattuale dei sindacati. Le figure professionali a bassa qualificazione sono state sostituite, con un più serrato utilizzo degli investimenti, con l’esternalizzazione delle attività non strategiche e in generale con personale immigrato, che ha minori aspettative salariali (le retribuzioni degli immigrati sono pari al 62% di quelle medie di tutti i lavoratori). Viceversa sono aumentati il potere contrattuale e le retribuzioni nei livelli alti delle qualificazioni professionali, anche tecniche, che sono essenziali e complementari alla crescita della competitività e della redditività delle imprese. Queste qualificazioni sono spesso di difficile reperimento: in Germania, la cancelliera Angela Merkel si è resa conto che per far fronte alla maggiore domanda di personale qualificato da parte delle imprese – causata anche da una seria riduzione della popolazione in età lavorativa – non restava che attrarre tecnici e laureati con politiche coraggiose di gestione dei flussi migratori. Per il nostro paese, se si vuole fronteggiare questo problema, ci sono solo due soluzioni. La prima, quella adottata dai maggiori paesi industrializzati e auspicata dallo stesso Consiglio europeo, è investire sulla conoscenza, sulla ricerca e sull’innovazione, così da elevare il livello d’istruzione e di competenze professionali, affinché possano essere competitive sul mercato del lavoro. Noi che facciamo in questa direzione? Niente. Basti pensare che la nuova strategia europea ha fissato come obiettivi per il 2020 quelli di portare al 3% del pil l’investimento in ricerca e sviluppo e di aumentare al 40% la percentuale dei giovani laureati: ma l’Italia ha stabilito che sono obiettivi troppo ambiziosi e che la spesa per la ricerca fra dieci anni non andrà oltre l’1%, così i giovani laureati, grazie anche ai tagli all’istruzione, non saranno più del 27%. Sempre la Merkel ha varato un piano di risanamento del bilancio che prevede tagli complessivi per 80 miliardi di euro, ma contestualmente ha previsto un aumento della spesa per l’università e la ricerca di circa 13 miliardi di euro. Come ho detto prima, in Italia rischiamo semplicemente di rassegnarci alla stagnazione. Per colpa non solo del governo ma anche del sistema produttivo, troppo frammentato per investire in ricerca e innovazione e che quindi esprime una domanda modesta di figure professionali altamente qualificate. La seconda soluzione riguarda i lavoratori dei settori dove s’impiega un gran numero di operai con basse qualificazioni, come il settore dell’auto: qui l’alternativa è rinunciare a produrre automobili o riuscire a produrle in modo più efficiente, per poter competere con le imprese dei paesi emergenti. Scambiare, insomma, maggiore efficienza e produttività in cambio del mantenimento dei livelli occupazionali e di migliori salari. In Germania, i lavoratori e i sindacati della Volkswagen hanno vinto questa scommessa senza rinunciare ai loro diritti e con salari che sono il doppio di quelli dei lavoratori della Fiat. In Italia si è semplicemente eluso il problema con giustificazioni ideologiche e senza accettare la sfida, correndo il rischio che Fiat possa investire sempre meno in Italia; e i lavoratori debbono continuare ad accontentarsi di buste paga da Terzo mondo. Marchionne ha posto, forse troppo brutalmente, i termini reali dell’alternativa, la Fiom ha risposto negando l’esistenza del problema, non firmando il contratto e facendo pagare solo ai lavoratori i costi della ristrutturazione. Per ora si è posta con maggiore forza la questione del sistema industriale italiano nel suo complesso, chiamando in causa e sollecitando alla riflessione anche i vertici confindustriali. […] gg