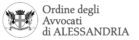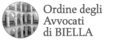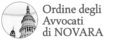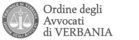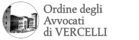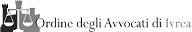«Le élites non sono riluttanti a esercitare dominio e predominio – come se si modellassero sull’esempio di Cincinnato – ma a essere qualcosa di più che un insieme di privilegiati; cioè, appunto, ad assumersi le responsabilità tipiche delle élites. È questa riluttanza – di cui ora stiamo pagando il prezzo – uno dei principali problemi del Paese». È quanto afferma Carlo Galli in I riluttanti. Le élites italiane di fronte alla responsabilità. Le élites in Italia, lungi dall’esibire l’orgoglio del merito e della selezione, aspirano piuttosto a essere vip; anziché vigilare sulle forme di cooptazione e di addestramento dei propri membri, allentano le deontologie, rilassano le pratiche di controllo, chiudono un occhio su insufficienze e infrazioni: si arraffa quel che si può nel presente, ci si adatta a un contesto degradato, a una società che è prevalentemente una mistura di interessi, di lobbies e di cricche. Questo cinismo delle élites è uno dei volti della loro riluttanza, comporta la corrosione dello spazio pubblico ed è, naturalmente, anche la fine della morale delle élites. Ci sono quindi molti motivi per censurarle, ma una loro condanna generalizzata e sommaria non ha senso. È vero che possono essere accusate di pigrizia, mancanza di cultura e di senso della responsabilità, ma è anche vero che in alcune circostanze hanno dato discreta prova di sé. Il possibile avvio di una terza nascita dell’Italia […] Il governo Monti ha una legittimità formale (ha la maggioranza in parlamento); ha una legittimità davanti al momento presente, cioè davanti a quella specifica e particolare contingenza che è l’emergenza (che non può azzerare, ma che può tentare di gestire – certo, in un’ottica di compatibilità col neoliberismo, ma almeno di compatibilità decente –, agendo in nome della salus populi sotto le specie della stabilità finanziaria e della ripresa economica); e può avere una legittimità storica, perché può essere l’inizio di un ritorno all’impegno delle élites riluttanti; e quindi, se sarà la prima fase di una grande decisione egemonica (il che non è per nulla detto), potrà avere la legittimità del futuro. Certo, le élites dovranno non solo essere all’altezza del momento presente – cioè far ripartire l’Italia, ovvero propriamente ‘dirigere’, anche con tratti pedagogici –, ma dovranno anche rinnovarsi, ovvero dare spazio a élites nuove: come le élites pre-unitarie furono capaci (in alcune loro parti avanzate) di avere un disegno nazionale, come le élites che misero fine al fascismo si aprirono, per amore o per forza, a nuove élites che gestirono la rinascita del Paese; così la pedagogia, che oggi è quella dei professori (se avranno sufficiente accortezza, l’autentica capacità egemonica, la necessaria energia politica per portare a termine il loro lavoro), dovrà diventare la pedagogia di rinnovati partiti e di élites sociali (anche sindacali) che, depurati dalle molte scorie che ora li appesantiscono, avranno il compito di ritrovare prestigio e proporre una qualche forma riconoscibile a questa società (e potrebbe non essere necessariamente una forma neoliberale, se le élites non neoliberali dimostreranno la capacità politica di intercettare autentici bisogni sociali diffusi). Certo, tutto è ancora possibile. Che il governo Monti fallisca o vivacchi, che le élites non si rinnovino, che le logiche e le persone del vecchio regime – il combinato disposto del populismo e del corporatismo (nel frattempo incattivitosi) – vengano riconfermate da un passaggio elettorale. L’analisi politica non è profezia, proprio perché la storia è contingenza e non necessità, perché le sue vie sono chiare solo ex post, mentre nel presente sono piuttosto sentieri tortuosi, e spesso anche interrotti; soprattutto, perché l’energia politica per far muovere la società non è necessariamente a disposizione. Quello che si può dire è che il durissimo 2012 potrà, con molta fortuna e molto impegno, essere l’avvio di una terza nascita dell’Italia se le élites politiche e sociali sapranno operare una sospensione della loro riluttanza; per essere le ostetriche di questa terza nascita le élites sociali dovranno farsi carico di uscire dal loro eterno presente, e, cessando di comportarsi come se la politica (ovvero il futuro) non esistesse, dovranno sforzarsi di creare non poche isole più o meno d’eccellenza, ma una rete diffusa di saperi e di soggettività autorevoli, efficaci, dotate di forte ethos professionale e di capacità innovativa. Le élites politiche – i partiti – dovranno, da parte loro, uscire dalla colpevole minorità che ne fa dei portatori passivi di interessi lobbistici e rientrare nella logica (democratica, pluralistica) dell’egemonia, cioè della concorrenza fra progetti che nascono inevitabilmente di parte ma che si offrono come orizzonte valido per tutti; dovranno combattere credibilmente contro il cinismo, la passività, il conformismo, la corruzione, come hanno iniziato a fare, in una certa misura, quando nella primavera del 2011 hanno saputo, non senza difficoltà ed esitazioni, accompagnare alla vittoria i sindaci che esprimevano l’ansia di cambiamento di gran parte degli italiani. Si deve segnalare, in chiusura, che si tratta di prospettive che vanno ben oltre quelle del governo Monti. E che non sono prospettive di parte. Benché la politica non possa non avere un’origine parziale, e quindi non possa non essere declinata polemicamente (all’interno di regole democratiche), che le élites trovino nuovo coraggio e nuovo realismo e un’esigenza che interpella non questa o quella parte politica, ma tutto il Paese. Naturalmente, se questo vuole ancora preoccuparsi del proprio futuro, se si sforza di vedere oltre l’emergenza. gg