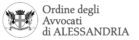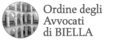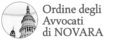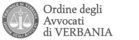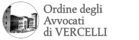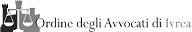Raggiungere la verità nel processo giudiziario è possibile, opportuno ed essenziale. Oltre che fondamentale per il funzionamento di una società realmente democratica. È la tesi che Michele Taruffo argomenta con forza e che, non scontata né banale, è da tempo discussa da prospettive giuridiche diverse. Dalla ricostruzione storica del dibattito ideologico alla analisi delle dinamiche narrative che intervengono in un processo, Taruffo chiarisce temi complessi, in una fase in cui in Italia si parla di giustizia con semplicismo e in modo, spesso, strumentale. Il valore determinante della verità come condizione per il buon funzionamento dei rapporti sociali trova una chiara conferma anche in una diversa prospettiva di analisi. Formulando il principio di cooperazione che governa la conversazione, Paul Grice si riferisce specificamente alla qualità della conversazione che si regola sulla base di tale principio, e formula la “supermassima” secondo la quale chi partecipa alla conversazione dovrebbe tentare di contribuire ad essa in modo veritiero. Questa regola generale si articola in due regole più specifiche secondo le quali: a) non bisogna affermare ciò che si sa essere falso; b) non bisogna fare affermazioni per le quali mancano prove adeguate. Anche in questa prospettiva, dunque, un momento fondamentale della dinamica sociale fonda il proprio buon funzionamento sulla condizione costituita dalla verità di ciò che si dice. L’onestà del ragionare, invero, richiede anzitutto che si rispetti la verità dei fatti. Il secondo aspetto della verità come valore sociale ha carattere eminentemente politico, e consiste nella connessione tra verità e democrazia. Questa connessione non è nuova: già Eduardo Couture, in una delle sue Meditaciones sobre la libertad, aveva richiamato un discorso di Roosevelt per sottolineare come la verità sia una connotazione necessaria del rapporto tra lo Stato democratico e i suoi cittadini. D’altronde, come ben sapevano il dottor Goebbels, Stalin e molti altri prima e dopo di loro, l’uso sistematico della menzogna e dell’inganno è stato storicamente un tratto caratteristico dei regimi totalitari. Vi sono tuttavia fatti recenti che hanno fatto tornare al centro dell’attenzione il rapporto tra politica e verità. Gli esempi non mancano, ma è sufficiente far riferimento alla menzogna raccontata da George W. Bush al popolo americano, e a tutto il mondo, circa l’esistenza di armi di distruzione di massa nelle mani di Saddam Hussein, con lo scopo di mistificare la realtà delle ragioni che spingevano alla guerra contro l’Iraq. Divenne poi evidente che quelle armi – poi ironicamente definite come weapons of mass distraction – non esistevano, e che Bush aveva tentato di legittimare con una colossale menzogna una brutale azione di Realpolitik. Non può apparire casuale, allora, che in questi ultimi anni si ponga un’enfasi nuova sul nesso diretto che intercorre tra la verità nei rapporti tra Stato e cittadini e il carattere democratico del sistema politico. Così, ad esempio, si è sottolineato che la verità è una condizione necessaria per la fiducia che il cittadino dovrebbe avere nello Stato, fiducia che deve fondarsi sul principio che lo Stato non dovrebbe ingannare i cittadini. Inoltre, la verità è una condizione necessaria per l’esercizio delle libertà che ai cittadini debbono essere riconosciute: la falsificazione o la soppressione dell’informazione è un limite grave al possibile esercizio della libertà. Appare poi particolarmente forte l’argomento anti-tyranny secondo il quale le azioni illegittime ed errate compiute da chi esercita il potere debbono poter essere scoperte, ma ciò implica che informazioni veritiere siano disponibili per le potenziali vittime del tiranno, in modo che queste possano controllare le modalità con cui il potere viene esercitato. Pare dunque evidente che la cura per la verità è una componente essenziale della democrazia: per uno Stato democratico è sempre sbagliato mentire ai cittadini. Questi, d’altronde, non sono in condizione di formarsi opinioni corrette e di esercitare il loro diritto di critica se sono immersi in un sistema fondato sulla menzogna e sulla soppressione della verità. È chiaro, per contro, che un sistema fondato sulla verità è democratico in quanto garantisce ai cittadini la libertà di compiere scelte non manipolate intorno a ciò che i cittadini stessi preferiscono, relativamente a tutti gli aspetti della vita individuale e sociale. Ne consegue che la stessa esistenza dei diritti fondamentali, che è essenziale in un sistema democratico, trova fondamento in una concezione oggettiva della verità: se si hanno a cuore i valori della democrazia, bisogna avere a cuore la verità. A fronte di argomentazioni come queste, la reazione dello scettico appare ovvia: la politica non è fatta da anime candide che si preoccupano della verità; l’esercizio del potere si fonda sistematicamente sulla menzogna e sulla manipolazione; tener nascosta la verità è spesso indispensabile, e così via. Né il principe di Machiavelli né il Leviatano di Hobbes, dopotutto, possono essere considerati come strenui difensori della verità. Considerazioni siffatte contengono, naturalmente, molto di vero. Tuttavia si può osservare che esse si riferiscono alla politica, e più precisamente alle non sempre confessabili pratiche della Realpolitik, ma non hanno nulla a che vedere con le regole che dovrebbero essere seguite in un sistema autenticamente democratico. Vero è che anche i sistemi democratici debbono fare i conti con le necessità della politica, e quindi è inevitabile che la verità subisca limitazioni e deroghe. Ciò implica peraltro che si tratti soltanto di eccezioni al principio di verità. Inoltre queste eccezioni – che non dovrebbero mai diventare la regola – debbono trovare adeguate giustificazioni nell’esigenza di attuare finalità che possano talvolta prevalere sull’applicazione di tale principio. In altri termini: in un sistema davvero democratico il principio di verità può trovare attenuazioni, ma la relativa decisione non può essere arbitraria, deve pur sempre essere soggetta a controllo e non può fondarsi sulla menzogna e sulla manipolazione dell’opinione pubblica. Come ha sottolineato Williams, vi sono casi nei quali le necessità della politica possono giustificare il segreto, ma la menzogna non può mai essere giustificata. Benché sia «strumento ordinario della vita pubblica», la menzogna intenzionale dovrebbe trattarsi come crimine contro la democrazia. Non ci si può tuttavia nascondere che anche sistemi politici che amano definirsi democratici, e che vengono spesso indicati come modelli di democrazia, non di rado compiono opere di sistematica disinformazione e di manipolazione dell’opinione pubblica, come insegna il caso – ma gli esempi potrebbero essere numerosissimi – di Bush e della guerra in Iraq. Tuttavia il fatto che ciò accada non dimostra in alcun modo che la democrazia sia indifferente alla verità nei rapporti tra il potere politico e i cittadini; dimostra soltanto che spesso i sistemi che amano definirsi democratici sono assai meno democratici di quanto si pensi. Il grado di adesione concreta al principio di verità appare, invero, come un efficace metro di misura del grado di democrazia effettivamente esistente in un regime politico. Se, in questa prospettiva, si pone mente alla molteplicità dei casi in cui in Italia, in anni recenti, si sono nascosti e manipolati fatti rilevanti, e quindi si è nascosta la verità, vien fatto di avere seri dubbi circa la natura democratica del sistema politico italiano. D’altronde, se chi detiene il potere pretende di imporre a tutti “verità” stabilite a priori, in modo dogmatico e autoritario, ciò che si verifica è l’esatto contrario della democrazia: non è certamente la verità ad essere antidemocratica, ma lo è la pretesa di imporre a tutti la “verità” di qualcuno. È questa pretesa “verità”, che di regola non è vera affatto, ad avere un’effettiva “forza antidemocratica”. gg